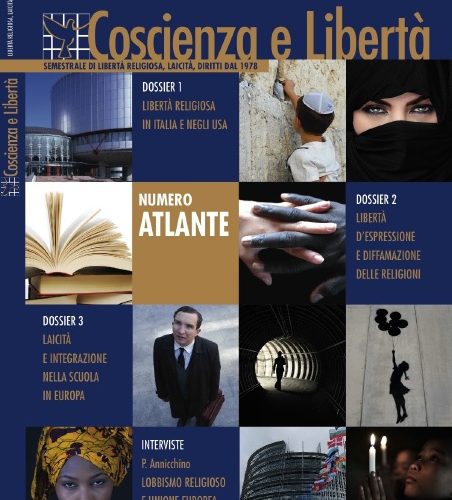Introduzione
Negli ultimi anni le religioni si sono trovate al centro di due importanti processi di trasformazione: da un lato, esse hanno riacquistato un rilievo pubblico che avevano da molto tempo perduto; dall’altro, hanno accentuato il loro profilo identitario. Da decenni le religioni non trovavano tanta attenzione nel mondo della politica, della cultura, della diplomazia: e ciò è avvenuto anche (soprattutto?) perché esse si sono rivelate in grado di parlare «il linguaggio pubblico delle politiche di identità» (1), fornendo una chiave interpretativa della realtà e un senso di appartenenza a persone schiacciate da un mercato dove vige la legge del più forte (come ha sottolineato in un recente saggio Guido Rossi) (2), deluse da un diritto che ha rinunciato al tentativo di assicurare la giustizia (è la conclusione a cui perviene Natalino Irti scrivendo di nichilismo giuridico) (3) e spaventate da un progresso scientifico e tecnologico che diventa regola a se stesso (4).
Questa duplice trasformazione va analizzata con attenzione perché genera tensioni che è necessario imparare a governare. Nelle pagine che seguono si svol- gerà una iniziale riflessione su questo tema, ripercorrendo sinteticamente il processo storico che ha portato alla situazione attuale, indicando i caratteri dei conflitti a cui essa dà luogo e prospettando una strada per tentare di comporli.
Religioni e nazioni
Il periodo storico che va dalla metà del diciannovesimo secolo alla fine della prima guerra mondiale è correntemente definito l’età dei nazionalismi. L’idea di nazione racchiude l’identità culturale e politica di un popolo e l’istituzione espressiva di questa identità, lo Stato, trova la sua legittimità nella corrispondenza ad una nazione: lo Stato, scriveva Pasquale Staninslao Mancini, è l’ordinamento giuridico della nazione. Naturalmente vi sono eccezioni alla regola così come importanti differenze: i problemi non si pongono negli stessi termini nei vecchi Stati-nazione, come la Francia o la Spagna, e in quelli più nuovi, l’Italia e la Germania per esempio. Esiste però un elemento comune: il processo di costruzione o di consolidamento dell’identità nazionale passa attraverso il ridimensionamento di tutte le identità particolari. Le culture, le lingue, i mercati locali declinano e il loro posto viene più o meno rapidamente preso dai loro corrispettivi nazionali. Lo Stato-nazione rivendica il monopolio del patriottismo e non è disposto a spartirlo con altri soggetti: la religione della patria – come si vedrà con chiarezza nella prima guerra mondiale – è l’unica a potere legittimamente pretendere il sacrificio della vita dai suoi fedeli, i cittadini. Le religioni e le comunità religiose subiscono l’impatto di questo processo poiché rappresentano, almeno potenzialmente, centri alternativi di identità e di patriottismo che vanno ricondotti sotto il controllo dello Stato-nazione. Questa operazione può essere gestita in modo differente a seconda delle caratteristiche proprie di ciascuna religione. Alcune di esse si prestano infatti ad essere organicamente assorbite all’interno della dimensione nazionale. L’esempio più limpido è quello delle Chiese ortodosse: esse sono prive di un centro di governo sovra-nazionale (l’autorità del patriarca di Costantinopoli è poco più che nominale) e il potere reale risiede nelle Chiese autocefale, che spesso hanno gli stessi confini degli Stati in cui vivono; in molti casi inoltre (si pensi ai Balcani sotto la dominazione ottomana) le diverse Chiese ortodosse hanno rappresentato il centro dell’unità nazionale che ha permesso a popoli soggetti a una dominazione politica e militare straniera di salvaguardare la propria identità. Questi eventi storici e queste caratteristiche teologico-giuridiche rendono possibile l’identificazione della Chiesa con una nazione e quindi con lo Stato che ne è l’espressione. Le nozioni – tipicamente ortodosse – di sinfonia tra Stato e Chiesa e, soprattutto, di territorio canonico esprimono bene questa dinamica: il territorio su cui lo Stato esercita la propria sovranità corrisponde di fatto al territorio su cui la Chiesa rivendica il proprio monopolio rispetto a tutte le altre religioni. Naturalmente questa comunanza non esclude l’insorgere di conflitti, anche gravi, tra Stato e Chiesa: fornisce però un contesto di interessi convergenti che aiuta a comporre e risolvere i contrasti.
Le religioni caratterizzate da una più forte dimensione sovra-nazionale – e in particolare il cattolicesimo latino – si trovano in una situazione più difficile. La Chiesa di Roma è ancora percorsa, nell’Ottocento, dalla nostalgia per un modello politico imperniato sul rapporto tra due autorità sovra-nazionali, quella del papa e dell’imperatore: questo modello ha iniziato a sbriciolarsi proprio con l’emergere, alla fine del Medioevo, degli Stati nazionali che hanno rivendicato il diritto di controllare l’organizzazione della Chiesa nel proprio territorio, inclusa la nomina dei vescovi. Fin dall’inizio, quindi, la formazione degli Stati nazionali (con la correlata possibilità della costituzione di Chiese nazionali) è stata percepita dalla S. Sede come una minaccia all’unità della Chiesa e alla sovranità del pontefice. Questo retroterra storico spiega il sospetto con cui, ancora nell’Ottocento, alcuni Stati europei considerano i propri cittadini di religione cattolica, mettendone in dubbio il patriottismo e la lealtà alla causa nazionale: i cattolici inglesi sono definiti «papisti» e una parte di quelli francesi «ultramontani» proprio perché accusati di guardare al di là delle Alpi e riconoscere come propria, suprema autorità una persona, il papa, che è un soggetto straniero.
Lentamente, nei primi decenni del Novecento, questo sospetto si stempera. Durante la prima guerra mondiale la S. Sede mantiene una stretta neutralità ed evita di appoggiare una qualsiasi tra le parti in lotta; negli anni immediatamente successivi, cede una parte del proprio potere agli episcopati nazionali (attraverso il rafforzamento delle conferenze episcopali) e incoraggia la costituzione di partiti cattolici, attraverso cui i fedeli della Chiesa di Roma partecipano alla vita politica degli Stati di cui sono cittadini. Ma il conflitto tra identità nazionale e identità religiosa, che fortunatamente non assume quasi mai i contorni di una guerra, non si chiude in parità: è la prima a prevalere e a dettare le condizioni su cui si trova, tacitamente, l’accordo. In molti paesi europei il tramonto del confessionismo di Stato segnala che la religione non svolge più il ruolo di simbolo dell’identità nazionale che, almeno formalmente, aveva conservato fino alle rivoluzioni liberali di metà Ottocento: le religioni, al plurale, sono ormai identità collettive particolari che si inscrivono all’interno di un firmamento dominato dall’idea di nazione, che non ha più bisogno di alcuna stampella religiosa per affermare la propria supremazia sulla vita dei cittadini. E anche dove il confessionismo di Stato sopravvive, esso si riduce progressivamente a formula vuota di contenuti (come nei paesi dell’Europa settentrionale) oppure a indicazione di una componente importante – ma settoriale e non esclusiva – dell’identità nazionale.
Religioni, ideologie e diritti umani
La fine della prima guerra mondiale apre nuovi orizzonti. I soggetti politici e culturali dominanti a partire dalla metà dell’Ottocento, le nazioni, debbono misurarsi con un nuovo antagonista: i grandi movimenti ideologici e politici a carattere universale, come il comunismo o il fascismo. Essi sono contraddistinti da un messaggio e da un programma sovra-nazionale e sono capaci di suscitare una solidarietà e un patriottismo che attraversa i confini degli Stati. Gli Stati nazionali, che avevano vinto la propria battaglia contro i centri sub-nazionali di identità collettiva, debbono ora misurarsi con un nuovo e ancor più pericoloso soggetto identitario a carattere sovra-nazionale.
La risposta a questa nuova sfida non può essere cercata soltanto a livello nazionale: il confronto si colloca su un piano più alto ed esige di essere affrontato anche a questo livello. Una soluzione prende forma dopo la seconda guerra mondiale e consiste nella traduzione giuridica del discorso sui diritti universali dell’uomo. Le grandi dichiarazioni e convenzioni sui diritti umani non sono soltanto una reazione agli orrori del nazismo e del fascismo, ma anche una risposta al comunismo, l’ultima ideologia universale sopravvissuta al secondo conflitto mondiale. Esse offrono una prospettiva altrettanto globale ed aspirano a divenire l’oggetto di un nuovo patriottismo indirizzato verso la difesa del «mondo libero»: quest’ultimo – caratterizzato dalle libertà politiche, la libertà di stampa, di religione e via dicendo – viene costruito come l’alternativa a livello sovra-nazionale al mondo comunista, dove queste libertà sono largamente assenti.
Le religioni non mancano di essere coinvolte in questo cambiamento di prospettiva. Esse non possono competere con i diritti fondamentali della persona umana sul terreno dell’universalità: anche le grandi religioni sovra-nazionali – l’islam, il cristianesimo, il buddismo – non sono così universali come i diritti umani pretendono di essere. All’interno di un orizzonte definito da diritti che si applicano ovunque e ad ogni persona, le religioni debbono accontentarsi di un posto particolare e più circoscritto. Questa collocazione emerge con chiarezza nella formulazione giuridica dei diritti umani: quando l’articolo 2 della Dichiarazione del 1948 proclama che i diritti contenuti nella Dichiarazione spettano a chiunque senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione e via dicendo, esso afferma che i diritti universali debbono essere rispettati indipendentemente dalle caratteristiche particolari degli individui, tra le quali viene collocata la religione. Basta riflettere sul diritto di libertà religiosa per accorgersi che tanto gli Stati quanto le religioni devono ormai fare i conti con questa nuova universalità giuridica. Le convenzioni internazionali proteggono gli individui contro le violazioni della libertà religiosa compiute non soltanto dagli Stati, ma anche dalle comunità religiose: se un gruppo religioso impedisce ai propri fedeli di cambiare la propria religione, quel gruppo diviene problematico dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Le identità religiose e quelle nazionali, che si erano trovate contrapposte qualche decennio prima, devono ora misurarsi entrambe con i diritti fondamentali umani, che limitano tanto la sovranità delle nazioni quanto – in misura più ridotta – l’autonomia delle religioni. Il campo in cui queste si muovono non è più definito soltanto dal diritto costituzionale degli Stati in cui esse vivono, ma anche dal diritto internazionale che, attraverso i diritti dell’uomo, tende ad affermare il primato della coscienza individuale sui diritti delle collettività religiose.
Religioni e globalizzazione
Ma questa non è la fine della storia. La caduta del comunismo, nel 1989, elimina l’ultimo ostacolo alla globalizzazione: il nuovo mondo che prende forma negli ultimi venti anni è dominato da questa dimensione che interessa l’economia, la tecnologia, i mezzi di comunicazione, il mercato del lavoro e via dicendo. La sua principale caratteristica è la deterritorializzazione, l’assenza di confini e di patrie. Anche il diritto deve essere concepito in questi termini poiché, per essere applicabile globalmente, non può portare il segno di un paese o una tradizione giuridica particolare. Come ha rilevato Natalino Irti, Kelsen e la sua Teoria pura del diritto divengono il simbolo dell’affrancamento del diritto da un territorio (5). Il trionfo della dimensione universale e globale su quella particolare e locale appare completo: né gli Stati nazionali né le religioni sembrano conservare la forza di opporsi a questo processo.
Ma poi accade qualcosa di strano e di imprevisto. Più la globalizzazione diviene dominante, più emerge il bisogno di una dimensione locale, radicata in un luogo specifico, con le sue tradizioni, il suo linguaggio, la sua religione; più il territorio perde significato, più si sente la nostalgia di un confine che distingua chi sta dentro da chi sta fuori, poiché l’identità non può essere costruita senza un «altro» diverso da me che mi aiuti a capire chi sono io. Anche i giuristi risentono di questo mutamento di clima: l’opera di Carl Schmitt torna a riscuotere interesse e il suo «Nomos della terra» costituisce la riaffermazione del legame tra il diritto e un territorio.
Ancora una volta le identità religiose sono profondamente interessate da questo cambiamento di rotta, dettato dal bisogno di radici, tradizioni, appartenenza: tutti beni che le religioni sono capaci di fornire assai efficacemente, perfino meglio degli Stati nazionali che appaiono spesso troppo piccoli e indifferenziati per essere credibili antagonisti della globalizzazione.
Il primo risultato di questo scenario è una nuova versione della vecchia saldatura tra nazionalismo e religione: ciò che accade nei Balcani lungo gli anni ’90 fa comprendere che il comunismo aveva congelato, ma non risolto, i problemi. Attraverso un processo cruento la cartina geografica di questa parte dell’Europa torna quella degli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, alla fine dell’età dei nazionalismi. Non avere intuito per tempo che, saltato il coperchio del comunismo, nazionalità e religioni avrebbero rivendicato, senza fare sconti a nessuno, il loro vecchio posto è stato un errore di ingenuità: una lettura più accorta della storia di questa parte dell’Europa avrebbe mostrato che il pericolo di una identificazione tra religione, nazione e cultura era sempre vivo e avrebbe potuto tradursi in ogni momento – come infatti è avvenuto – in una tragica realtà.
Ma al tempo stesso prende forma un fenomeno diverso e più nuovo. Nell’età della globalizzazione, la patria dell’identità ha sempre meno la dimensione del territorio e sempre più quella dell’appartenenza. La dialettica non corre soltanto – e neppure prevalentemente – tra il diritto spaziale (o globale) del mercato e il diritto territoriale (o locale) delle identità: l’identità si libera dal legame ad un territorio e si configura come appartenenza capace di attraversare i confini. Proprio i diritti delle grandi religioni forniscono questa possibilità: da un lato, essi rimandano a qualcuno o a qualcosa in grado di produrre senso, di fornire una chiave interpretativa della realtà capace di dare valore all’agire umano; dall’altro, le loro regole – che prescrivono pellegrinaggi, giorni di festa, periodi di digiuno per l’intera comunità – costruiscono e scandiscono nella vita quotidiana un senso di appartenenza che scalda il cuore e motiva all’azione ben più delle fredde leggi del mercato sottese al diritto spaziale. Ma soprattutto i «teo-diritti» si collocano in una dimensione capace di superare, senza rinnegarla, la propria origine territoriale. Questo è l’elemento che negli ultimi anni più è venuto alla ribalta: la capacità delle grandi religioni e dei loro diritti (a differenza degli Stati e dei loro diritti) di superare i confini senza perdere la forza di attrazione che deriva da una identità e da una appartenenza storicamente e geograficamente collocate. Gerusalemme, Roma, La Mecca e tanti altri luoghi e città sante restano il punto di riferimento delle grande religioni, ma non ne limitano le potenzialità espansive. L’islam europeo è un buon esempio di questa appartenenza che, in nome di un diritto sacro, si pone in alternativa tanto al diritto territoriale degli Stati europei quanto al diritto spaziale del mercato: l’umma, la comunità musulmana travalica i confini degli Stati e delle etnie a partire da una identità fondata nella comune fede e pratica religiosa. Ma non si tratta di un caso isolato: una dinamica analoga attraversa la comunità ebraica sparsa nel mondo o i movimenti evangelici dei «born again» che accomunano il manager statunitense che vive a New York al campesino messicano del Chiapas. In tutti questi casi il luogo dell’identità e dell’appartenenza non è definibile in termini geografici: esso attraversa i confini territoriali senza però annullarsi nella dimensione spaziale che caratterizza il mercato globale.
Se si volessero riassumere queste osservazioni in uno slogan (con tutti i rischi di semplificazioni e forzature che sono connesse a questa operazione), si potrebbe dire che le religioni sono le nuove nazioni trans-nazionali. Da un lato, esse sono radicate in una tradizione e in una storia condivisa, forniscono una narrativa in cui è possibile riconoscersi, indicano una direzione per la vita di ciascuno e generano solidarietà tra i membri della comunità, alimentano la fede in un destino comune e sono capaci di scaldare i cuori dei loro fedeli ben più della universalità fredda dei diritti umani, che rischiano di essere i veri perdenti di questa partita: sono tutti caratteri che tradizionalmente hanno definito una nazione. Ma le religioni non sono immobilizzate su un territorio, attraversano i confini e, soprattutto, sono capaci di muoversi e di emigrare: cose che le nazioni difficilmente riescono a fare.
Le religioni e i loro «teo-diritti», così carichi di identità e appartenenza, sembrano dunque essere la risposta (o almeno una delle risposte più importanti) all’anonimo e spersonalizzante diritto spaziale prodotto dalla globalizzazione. Ma questa risposta non è senza problemi. La nuova valenza identitaria delle religioni e la loro capacità di movimento e di insediamento in territori nuovi genera conflitti: tra le religioni stesse, in difficoltà a sviluppare una convincente teologia dell’«altro» e un efficace dialogo ecumenico; con gli Stati nazionali, preoccupati della propria sicurezza e con le macro-aree caratterizzate da una storia e cultura comune (si pensi alle tensioni conseguenti alla presenza musulmana in Europa e protestante in America latina); con le dinamiche sottese al processo di globalizzazione, fondato su una razionalità efficientista che raramente le religioni condividono.
Religioni, conflitti e laicità dello Stato
I tre conflitti ora indicati presentano caratteristiche differenti che esigerebbero un’analisi assai più articolata di quella che è possibile compiere in queste pagine. È però utile – per decodificare la loro natura – segnalare almeno sommariamente qual è la componente dominante di ciascuno di essi.
Nel caso dei conflitti tra religioni, l’elemento che oggi ha maggiore importanza è la crescita della loro dimensione identitaria. In molte parti del mondo, era ed è ancora frequente la convivenza di persone che, pur avendo una religione differente, condividono la stessa cultura. È il caso, per fare un esempio, dei cristiani e dei musulmani che vivono in Egitto, Siria e altri paesi del Medio Oriente: diversi per religione, essi sono parte dello stesso mondo culturale arabo. Questa situazione non ha suscitato problemi particolarmente gravi finché le componenti identitarie della religione non hanno preso il sopravvento, accentuando il peso dell’appartenenza comunitaria, dei simboli che la esprimono e dei confini che la delimitano: a questo punto è divenuto difficile conciliare differenza di fede e identità di cultura, poiché la religione è percepita e vissuta come una appartenenza necessariamente produttiva di diversità culturale. L’alterità religiosa genera estraneità culturale e rende più problematica la convivenza delle diverse comunità sullo stesso territorio, generando tensioni che inducono fenomeni di ghettizzazione ed emarginazione o sfociano in aperti conflitti.
Diverso è il caso dei conflitti tra religioni e Stati nazionali. L’accentuazione del carattere identitario delle religioni non provocherebbe tanta preoccupazione negli Stati se non fosse accompagnata da una componente sopranazionale e da una accresciuta capacità di attraversare i confini, attraverso l’immigrazione o i mezzi di comunicazione: non è un caso che, negli ultimi anni, il tema della sicurezza nazio- nale sia entrato prepotentemente nell’area di interesse degli studiosi delle religioni (e dei loro diritti). Fino a pochi anni or sono, la sicurezza nazionale era di competenza esclusiva degli analisti politici e militari: oggi chi suscita maggiori preoccupazioni sono i terroristi in nome di Dio o i predicatori che incitano alla guerra santa.
Ancora differente è la tipologia dei conflitti che possono insorgere tra i diritti delle religioni e il diritto prodotto dalle agenzie della globalizzazione, che sono in grado di agire in proprio (si pensi ad una grande multinazionale) o attraverso l’influenza che esercitano sull’attività degli Stati. Il diritto della globalizzazione si ispira infatti a criteri di razionalità ed economicità che non sono sempre condivisi dai diritti sacri, ovvero quei diritti che regolano la vita di una persona a partire dalla sua fede e appartenenza religiosa. Questi, per esempio, possono scoraggiare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, prescrivere di digiunare durante il giorno (riducendo la produttività dei lavoratori) oppure ordinare di astenersi da ogni attività in un giorno particolare della settimana, cosa che è difficilmente compatibile con il pieno sfruttamento della capacità produttiva degli impianti.
Al centro di tutti questi conflitti sta un processo di ridefinizione dei confini entro cui si esercita il potere di religioni, Stati, organismi sopranazionali e transnazionali. Il fatto che le religioni siano diventate più capaci che in passato di attraversare i confini non significa infatti che essi siano spariti. Il confine è essenziale alla costruzione dell’identità, sia personale che collettiva, e quindi non può scomparire ma soltanto essere sostituito. Per un confine che svanisce, ce n’è un altro che si forma: se la linea che separa il cittadino dallo straniero appare oggi meno profonda, quella che divide il fedele dall’infedele diviene di giorno in giorno più marcata. Ma ciò che più importa è il pericolo che le due linee si confondano e si sovrap- pongano, riportando l’Europa ad una sorta di «cuius regio, eius et religio» [Cuius regio, eius religio («Di chi [è] il potere, di lui [sia] la religione»] deterritorializzato, in cui il conflitto non è più tra Stati ma tra comunità interne allo stesso Stato, tra contrastanti orientamenti religiosi ed etici trasversali alla società europea.
È difficile pensare che queste nuove tipologie di conflitto siano un fenomeno passeggero, destinato a scomparire nel giro di qualche anno: è più probabile che esse ci accompagnino per molto tempo e, di conseguenza, è necessario trovare il modo di governarle. È inutile cercare questa governance nella riaffermazione della priorità delle piccole patrie nazionali, che non hanno le dimensioni necessarie per affrontare il problema: la risposta va articolata a un livello più alto che, nel nostro caso, è quello europeo. Ma questo livello non può essere individuato in termini territoriali, come se l’Unione europea fosse semplicemente uno Stato dai confini più estesi: va immaginato in termini culturali capaci di organizzare lo spazio attorno ad una idea-forza. Nel caso dell’Europa questa idea è quella di laicità dello Stato.
La laicità dello Stato è l’unica idea che abbia la forza di sintetizzare le due componenti fondamentali della tradizione culturale europea: quella cristiana del «date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» e quella secolare dell’«etsi Deus non daretur». L’approccio alla nozione di laicità dello Stato indicato da queste due formule è diverso ma non incompatibile: l’«etsi Deus non daretur» rivendica il primato della ragione rispetto alla fede nel campo delle scelte pubbliche; il «date a Dio» segnala che c’è una parte che spetta a Dio anche in questo campo (e non solo in quello delle scelte private) (6).
Nessuno Stato – laico o non laico che sia – possiede la bacchetta magica che sarebbe necessaria per risolvere i conflitti indicati nel paragrafo precedente. Ma la laicità dello Stato può definire il terreno su cui essi debbono mantenersi e indi- care alcune regole – in particolare il rispetto del principio di ragionevolezza e di democrazia (7) – che debbono essere accettate da tutti i contendenti.
Questo obiettivo serve a selezionare, tra le tante e differenti funzioni che la laicità può svolgere, quelle che più servono allo scopo che si intende raggiungere. Nel contesto che si è cercato di descrivere, la laicità non va configurata come una laicità-programma, ma come una laicità-metodo, non è la laicità di cui parlano i filosofi e gli scienziati della politica, ma è innanzitutto la laicità dei giuristi: non ha la pretesa di informare ai propri valori la società civile ma quella, più modesta, di regolare i rapporti tra questa e lo Stato. Questa concezione pragmatica della laicità, intesa come strumento di regolazione del pluralismo sociale, assicura la mediazione del diritto che impedisce ad un solo sistema di valori (fosse anche quello della maggioranza) di impadronirsi delle istituzioni pubbliche.
Non si tratta dell’appello ad una chimerica neutralità dello Stato (8), quasi che in regime di democrazia lo Stato possa evitare di schierarsi e di scegliere secondo le indicazioni della maggioranza dei cittadini. Ma un conto è prendere posizione nella consapevolezza che ogni scelta traduce in maniera soltanto imperfetta e provvisoria i valori a cui è ispirata, un altro conto è presentare la propria scelta come espressione dell’unica verità possibile. Senza escludere che esista una verità, lo Stato laico dichiara la propria incompetenza ad accertarla e lascia questo compito di definizione e proposizione dei valori “ultimi” ad una serie di “agenzie” (tra cui le religioni), che agiscono in regime di pluralismo e nel rispetto dei principi della democrazia, da cui la legislazione statale può essere influenzata (in proporzione alla recezione di quei valori nel corpo sociale) ma non “confiscata” (nel senso che non può identificarsi con alcuno di quei sistemi di valori).
Una laicità che rinunci alla pretesa di proclamare le verità ultime e accetti il proprio ruolo – modesto ma fondamentale – di permettere agli uomini di ricercarle e affermarle è l’unica che può contribuire a creare uno spazio di dialogo che eviti la radicalizzazione del conflitto.
SILVIO FERRARI Professore ordinario di Diritto canonico presso l’Università Statale di Milano e presso l’Università di Lovanio. Articolo edito in Coscienza e Libertà 46/2012.
NOTE
1 E. Pace, Perché le religioni scendono in guerra?, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. x.
2 G. Rossi, «Homo homini lupus?», in Micromega, 2006, 2, pp. 76-86.
3 N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, Bari, 2004.
4 Cfr. le posizioni di E. Severino espresse in N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Bari, 2001.
5 N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Laterza, Roma-Bari, 2001.
6 Altrove ho cercato di indicare le strade per la composizione di questi due differenti punti di vista, sottolineando che la laicità di cui oggi abbiamo bisogno non può essere fondata su uno solo di essi: cfr. S. Ferrari, «Laicità dello Stato e pluralismo delle religioni», in Sociologia del diritto, n. 2, 2006, 531; Id, «Sul Trattato costituzionale europeo. Radici cristiane della laicità», in Il Regno-attualità, 15 settembre 2003, pp. 528-530.
7 Cfr. S. Ferrari, «Laicità dello Stato…», art. cit., pp. 9-11.
8 L’impossibilità di una tale neutralità è sottolineata in J. T. S. Madeley, Zsolt Enyedi (ed.), Church and State in Contemporary Europe. The Chimera of Neutrality, Frank Cass, London, 2003.